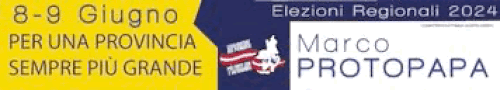di Enrico Sozzetti
di Enrico Sozzetti
Il coronavirus colpisce più pesantemente le aree ad agricoltura intensiva? La scienza non è per ora in grado di rispondere con elementi certi, però da un recente studio emerge una fotografia che deve fare cominciare a pensare sulla correlazione fra produzione, ambiente ed effetti sull’uomo. La ricerca è quella condotta dal laboratorio Cultlab della Scuola di Agraria dell’Università di Firenze in collaborazione con la segreteria scientifica dell’Osservatorio nazionale del paesaggio rurale e ha messo in relazione il numero di casi di coronavirus registrati a livello nazionale dalla Protezione Civile (dati aggiornati al 9 aprile) e i modelli di agricoltura. Cosa è emerso? Che nelle aree dove vi sono sistemi di agricoltura non intensiva si registra una minore incidenza del covid-19 rispetto alle aree ad agricoltura intensiva: 32 casi ogni 100 chilometri quadrati rispetto ai 94 ogni 100 chilometri quadrati registrati nelle zone agricole periurbane (prossime alle città) e ad agricoltura intensiva, mentre il parametro medio nazionale è di 47 casi per 100 chilometri quadrati, come si legge su una nota diffusa l’altro giorno.
«La nostra – ha spiegato all’agenzia Ansa il professor Mauro Agnoletti, coordinatore del progetto e responsabile scientifico del programma della Fao (Food and agriculture organization, Organizzazione delle Nazioni unite per l’alimentazione e l’agricoltura) per la tutela dei Paesaggi agricoli di rilevanza mondiale – è una fotografia. La spiegazione del perché, può solo proporre ipotesi legate ai meccanismi del contagio amplificati dalla concentrazione di attività agricole intensive, agroindustriali, aree urbane e industria tradizionale in aree di superficie limitata insieme alla maggiore densità di popolazione».

Lo studio ha preso in considerazione quattro modelli di agricoltura: aree agricole urbane e periurbane, aree ad agricoltura intensiva (come la pianura Padana; la cartina è tratta dalla pagina pubblicata su http://www.landscapeunifi.it), aree con agricoltura “a media intensità energetica” (dove si praticano sistemi tradizionali) e aree con agricoltura “a bassa intensità energetica” (tipiche delle zone di montagna del centro-nord, della collina rurale meridionale e in alcune aree di pianura del sud e delle isole). E il caso della pianura Padana è esemplare. Le province interessate sono quelle di Alessandria, Asti, Bergamo, Biella, Bologna, Brescia, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Forlì-Cesena, Gorizia, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Modena, Monza e della Brianza, Novara, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Pordenone, Ravenna, Reggio nell’Emilia, Rimini, Rovigo, Torino, Treviso, Udine, Varese, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza. Qui si concentra il 61 per cento delle aree ad agricoltura intensiva di tutta Italia e si registrano il 70 per cento dei casi di coronavirus.
La distribuzione «è differente – si legge sul comunicato – a seconda dei modelli agricoli praticati: nelle aree della pianura Padana ad agricoltura intensiva si registrano 138 casi ogni 100 chilometri quadrati, mentre in quelle dove l’agricoltura non è intensiva la media scende a 90 casi ogni 100. Le aree a media e bassa intensità energetica, dove sono concentrate il 68 per cento delle superfici protette italiane, risultano invece meno colpite dal covid-19».
Quali sono? Quelle medio collinari, montane alpine e appenniniche, caratterizzate «da risorse paesaggistiche, naturalistiche ma anche culturali, storiche e produzioni tipiche legate a criteri qualitativi più che quantitativi. Il modello di agricoltura, detto altrimenti, riflette uno stile di vita diverso rispetto a quello delle zone ad alta intensità energetica. Questo tipo di organizzazione produttiva, economica e sociale potrebbe rappresentare un modello di sviluppo da cui ripartire una volta passata l’emergenza» è la riflessione finale di Agnoletti. Sono sistemi agricoli, recita la parte conclusiva del comunicato, che possono garantire «sicurezza alimentare, oltre a sviluppo equilibrato di attività terziarie legate al turismo, all’agriturismo, al commercio, ai servizi e ai prodotti tipici».