Quando diversi anni uscì in Alessandria Il seme della follia, ebbi la malaugurata idea d’invitare un mio carissimo amico e la di lui moglie ad assistere con me alla proiezione delle venti del primo giorno di proiezione. Il programma era di quelli adolescenziali: film, pizza e birra, qualche parola al vento. Lui non è uno di quelli che si mastica horror, ma l’autore, dal mio punto di vista, meritava un percorso, per quanto occasionale.
In vita mia non ho mai assistito a nulla del genere in termini di “effetti mediatici”. Dopo pochi secondi dai titoli di testa, l’amico abbassò lo sguardo verso il pavimento per non rialzarlo più fino alla fine. La sua consorte decise di addormentarsi come un macigno. Ero esterrefatto e un po’ avvilito per averli convinti a venire al cinema.
La verità era che, novant’anni in due, avevano paura. Una fifa blu. Paura della storia, della sua intensità, delle Cose che si appalesavano, delle situazioni e delle atmosfere. Paura, letteralmente paura di un film. Adulti di mezz’età con funzioni dirigenziali in importanti aziende della mia città: uno se la faceva sotto, l’altra se n’era fuggita nel modo più semplice dal punto di vista fisiologico.
Per inciso, niente pizza alla fine del film. E i due scomparvero dalla mia vita per almeno un anno.
Il seme della follia, ben se lo ricorderanno i carpenteriani come il sottoscritto, è metafora pura, lontano anni luce da qualsiasi approccio vagamente realista. Ci sono state alcune storie scritte da Tiziano Sclavi per Dylan Dog che ne hanno rasentato il radicalismo semiologico e il simbolismo destrutturante. Non ci può confrontare nei normali termini di “trama”, plotline o personaggi/specchio dello spettatore in sala. È un trip mentale, che nelle mani di qualsiasi altro autore sarebbe divenuto un giochino intellettuale lontano mille miglia da quelle imprescindibili risonanze emotive che connotano, da sempre, la verosimiglianza dell’horror, l’unica – all’apparenza – vera ragione delle paure suscitate in un lettore o in uno spettatore.
Eppure per quelli come l’amico mio il film in questione risultava un’esperienza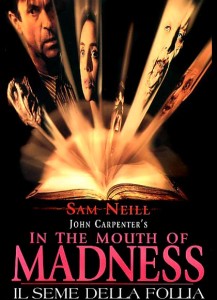 insostenibile. Da non poter richiedere, per quanto finzione, neppure l’alibi della visione. Sconcertante, vero? Eppure è così, non invento nulla. Perciò, rimuginando col tempo, mi sono chiesto cosa mai il mio amico avesse visto in quel film di così terrorizzante da non poter nemmeno essere guardato. Lo confesso, non ho mai trovato una risposta pienamente soddisfacente. Neppure quando venni a conoscenza della teoria di Jacques Lacan, celeberrimo psichiatra e filosofo francese, sul trou du sujet, il “buco nel soggetto”, un buco nell’elaborazione reale del materiale filmico che fa sì che, a livello inconscio, lo spettatore colto “in buca” si senta guardato a sua volta dallo Schermo, non reggendone per questa ragione lo sguardo. Più che suggestiva, ma scriverne è un conto. Vederne gli effetti nella sala buia a qualche centimetro da me è altra cosa. E, in realtà, a dissertare troppo di psicanalisi, il critico tende vistosamente a scantonare e a prendere cantonate, vecchia storia.
insostenibile. Da non poter richiedere, per quanto finzione, neppure l’alibi della visione. Sconcertante, vero? Eppure è così, non invento nulla. Perciò, rimuginando col tempo, mi sono chiesto cosa mai il mio amico avesse visto in quel film di così terrorizzante da non poter nemmeno essere guardato. Lo confesso, non ho mai trovato una risposta pienamente soddisfacente. Neppure quando venni a conoscenza della teoria di Jacques Lacan, celeberrimo psichiatra e filosofo francese, sul trou du sujet, il “buco nel soggetto”, un buco nell’elaborazione reale del materiale filmico che fa sì che, a livello inconscio, lo spettatore colto “in buca” si senta guardato a sua volta dallo Schermo, non reggendone per questa ragione lo sguardo. Più che suggestiva, ma scriverne è un conto. Vederne gli effetti nella sala buia a qualche centimetro da me è altra cosa. E, in realtà, a dissertare troppo di psicanalisi, il critico tende vistosamente a scantonare e a prendere cantonate, vecchia storia.
Comunque uno straccio di spiegazione doveva esistere. E riguardava proprio Carpenter e la sua ricerca della visione finale della Cosa. Per lui, demiurgo, una ricerca non ancora a tutt’oggi soddisfatta. Ma per qualche spettatore in sala gli effetti, i barlumi, le schegge disseminate in tale e tanta, coerente, quest, possono equivalere ad aprire – per pochi e terribili istanti – gli occhi su un mondo reale e parallelo, zeppo di Cose alla ricerca della propria Forma e per questo insostenibili allo sguardo, un mondo assolutamente interfacciato al nostro al punto da sentirne, di tanto in tanto, gli odori o di avvertirne le presenze o di vederne le Forme provvisorie.
In uno storico numero de Il Mucchio Selvaggio di quasi vent’anni fa, Maurizio Bianchini scriveva a proposito de La Cosa:
“La Cosa di Carpenter non viene dagli infiniti spazi siderali, né dalle oscure profondità dei cieli, ma da un luogo incomparabilmente più prossimo e distante. Viene dall’intimo di noi stessi: non ha forma, semplicemente perché può covare dentro ogni sentimento e vestire ogni emozione. Latita a tratti, finché non se ne risvegliano gli istinti distruttivi. Travolge tutto, perché non ci sono argini e convenzioni in grado di fare barriera una volta che gli incubi del profondo tornano ad emergere. La Cosa raffigura in modo simbolico e spettacolare quelli che Musil chiamava i Fantasmi dell’Altro Io”. (1)
Bianchini non sbagliava. Al punto che le considerazioni di allora possono ancora richiamarsi proprio per quel film realizzato nel 1994, appunto Il seme della follia, la più apocalittica opera di Carpenter nella quale il regista porta all’estrema esasperazione la virtuale compenetrazione tra i due mondi presenti nella realtà filmica e nel quotidiano di ciascun spettatore. Da un lato, lo ricordiamo, la finzione, rappresentata dai “finti” romanzi dello scrittore Sutter Cane, e la realtà del detective Trent, che si confrontano dall’altro, in un ossessivo gioco di specchi con l’ipotesi alla Philip K. Dick, da tempo calata e vissuta nella “nostra” realtà al di qua dello schermo, della sospensione di giudizio tra i diversi livelli di reale percepito in cui l’umana mente è costretta a vivere. Chi ci osserva (da dove non sappiamo – forse un immenso animale infernale di cui l’azzurro del cielo o la volta stellata sono soltanto piccole parti) crea forse la realtà che l’uomo è convinto di vivere, e ogni volta che un autore (da Dick a Carpenter) intende guardare chi ci sta guardando, tenta di portare a compimento un’operazione metatestuale di “rappresentazione dell’irrapresentabile”. Un incubo, un incubo onnipotente a occhi aperti. La realtà è tutta fuori campo, ogni suo inquadramento si scompone in una serie interminabile di altri incubi, ossessioni e follie. Ma può bastare solo questo a provocare la fuga dal film?
I grandi misteri del cinema. Soprattutto di quando ancora si riusciva ad andare al cinema…
(1) Maurizio Bianchini, La Cosa, Il Mucchio Selvaggio n° 61, Lakota, Roma 1983.






