 di Danilo Arona
di Danilo Arona
1) Ha abbandonato il pianeta nel gennaio 2017 dopo avere compiuto da poco 89 anni. William Peter Blatty, autore del testo forse più importante del gotico moderno (o “gotico gesuitico”, come amo definirlo). Se l’efficacia – strutturale, semantica ed emotiva – de L’esorcista va equamente divisa con William Friedkin, regista del film, le suggestioni demoniache e metafisiche stanno intatte tutte nel testo, e verranno ridistribuite pochi anni dopo l’uscita del film in due cult da riscoprire e da rivalutare, La nona configurazione del ’78 e L’esorcista III nel ’90, clamoroso capolavoro da pochi capito.
2) Ho lavorato molto su Blatty durante il 2016, avendo presentato il libro L’esorcista in due workshop a esternarne il valore in quanto testo esemplare da tener presente come (inarrivabile) modello per i neofiti scrittori di horror. Dovendo scegliere una “monografia” non ho avuto dubbi di sorta: L’esorcista è un esempio sublime di struttura (prologo in un Altrove – Iraq – e crescendo emozionale e cronologico in un contesto quotidiano, per metà una camera da letto…), corroborato da un tessuto “fantastico per esitazione” in cui viene inserito anche, quasi per rafforzare la connotazione realistica, il personaggio chiave della letteratura poliziesca, l’ispettore di polizia. Quel William Kinderman che tornerà in Gemini Killer, testo di derivazione per L’esorcista III, in un ruolo centrale per una nuova indagine ai confini del reale. Per evitare la trappola di quella che Laura Grimaldi definisce “romanzo a cinepresa fissa”, Blatty arricchisce, dinamizza la trama con sostanziosi flashback (il senso di colpa di padre Karras nei confronti della madre morta in casa di riposo), storie parallele (l’amicizia cinefiliaca tra padre Dyer e Kinderman), suggestivi esterni di Georgetown e sottotracce mitologiche (il demone Pazuzu, l’antico nemico che attende l’arrivo di Merrin accucciato dentro il corpo e la mente di Regan). Raramente l’effetto fantastico / horror è stato così efficace, così “invadente” da bucare il reale quotidiano, costringendoci a ricordare che il primo, basilare, principio di un horror riuscito – di quegli e di questi anni – è la verosimiglianza, la credibilità nei confronti di un evento per quanto sia quest’ultimo razionalmente non credibile. Plausibilità rafforzata dall’aver Blatty lavorato per tutti gli anni Sessanta nel campo della commedia brillante, soprattutto con Blake Edwards, affinando l’arte discorsiva soprattutto nel demandare ai dialoghi, fitti e serrati, quasi modellati “alla Hawks”, motivazioni e situazioni di solito “raccontate” dal regista. È anche grazie a questa tecnica di affabulazione “trasversale”, trasferita all’horror, che L’esorcista vanta una forza di penetrazione che un critico americano, Roger Elbert, così sintetizzò: «Questo film è un assalto frontale.»
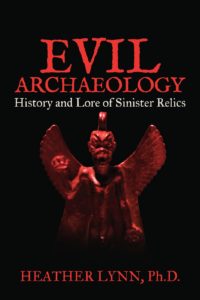
3) Se mai ci fossero delle conclusioni da tirare (ammessa e non concessa la liceità dell’operazione) per quel che riguarda il senso filosofico dell’horror in senso stretto, la prima reciterebbe che il Mostro senza l’uomo semplicemente non esiste o se c’è è ridicolo. È ovvio, il mostro si accuccia quasi sempre dentro l’uomo (come Mister Hyde, antesignano di Stevenson), oppure è l’uomo stesso che lo crea, come il dottor Frankenstein. Alla fine persino il Diavolo sarebbe una produzione umana (nello stesso Esorcista la prima manifestazione del demone, Capitan Howdy – Capitan Gaio nel doppiaggio italiano – metaforizza l’assente e lontano padre di Regan, Howard). Dracula non esisterebbe senza Van Helsing. Gli spettri di Quint e Miss Jessell (Giro di vite) non esisterebbero senza l’istitutrice. E potremmo andare avanti così ancora per molte righe.
Blatty però evita, da subito, il principio di causa/ effetto, spesso precorritore di banalità concettuali. A tre pagine dall’inizio del libro, annunciato solo da un formicolio “appena percettibile” sulla nuca di Merrin, il Male entra in scena e non è affatto un prodotto dell’uomo, se non nella sua ingannevole forma iconica di manufatto da appendere al collo:
«Era una pietra verde, la testa del demone Pazuzu, simbolo del vento di sud-ovest. Suo dominio era la la malattia, qualsiasi condizione patologica. La testa era forata. Il proprietario dell’amuleto lo aveva portato al collo come uno scudo protettivo.»
Tanto celebre è questo passo che si poteva pure evitare di riportarlo. Ma ho scelto di farlo per rimandare da un lato la memoria di ciascuno al magistrale incipit archeologico iracheno del film e dall’altro per ricordare un un particolare non da poco: che nel film il demone Pazuzu mai è nominato – per quanto “visto” – , mentre nel libro lo è con una certa precisione come abbiamo appena riscontrato.
Una scelta rigorosa. Pazuzu è il Male, un Male antico quasi in senso lovecraftiano, un male che contamina e che fa ammalare, e a suo modo L’esorcista è configurabile pure come un medical thriller. Alla stregua di un virus mutaforma, Pazuzu si nasconde e si modifica: da Capitan Howdy a Legione, da diavolo fornicatore a madre defunta di Karras. Una scelta che rimanda alla primaria ispirazione di Blatty.
In una fase particolare e stressante della sua vita, lo scrittore non era forse in grado di fronteggiare l’irruzione nel suo inconscio di contenuti archetipici. Vide una grande statua simile a un demone e ne restò colpito al punto da iniziare subito un’elaborazione mentale al suo riguardo. Quando scoprì la vera immagine di Pazuzu in un libro dei “Padri del Deserto”, considerò immediatamente di avere trovato il “contenuto” per quella “forma” psicoide, ed ecco così nascere il personaggio, niente affatto frutto di fantasia, che “Merrin ha già fronteggiato in un precedente esorcismo avvenuto in Africa”. Un demone sfuggente e irraggiungibile, con il quale ogni tentativo di dialogo è destinato a fallire. Perché alla fine si tratta di un’alterità disumana che opera un attacco incomprensibile all’umano raziocinio. Come abbiamo già scritto, il Male.
4) Edoardo Nesi, nella prefazione all’edizione Fazi (2009), ha scritto belle e importanti righe che s’inseriscono alla perfezione in queste note:
«…Come una malattia. Come se anche al demonio occorresse tempo per infestare un’anima, e ogni giorno l’infezione fosse più forte e ogni giorno presentasse un sintomo nuovo e orribile: ed è così che, pian piano, noi lettori facciamo conoscenza con una malvagità infinita e potentissima e incontrollabile che agisce sulle persone e le cose con una forza selvaggia, con un’oscena determinazione ad apparire e manifestarsi perché quello e soltanto quello sembra volere; una malvagità che ci convince perché fa compiere alla bambina atti innominabili, così orribili da sconvolgerci, ancora oggi. E mentre si legge, avvinghiati alle pagine, si diventa vittime di un meccanismo perfetto e poderoso che fa dipanare la storia in un lento, inesorabile crescendo che non ci lascia nessun punto di riferimento: non c’è niente di ovvio, niente di telefonato, niente di già letto nella catena di eventi che ci porta infine davanti all’incubo, all’orrore supremo. Per quanto si cerchi di non precipitare nella storia, non ci si riesce. Siamo in una carrozza coi vetri oscurati, e corriamo nella notte, senza sapere dove stiamo andando.»
E qui c’interrompiamo, rimandando a una seconda parte altri e singolari aspetti sulla modernità dell’archetipo diabolico.
-continua-



