Sabato scorso alla Casetta del quartiere Europa di Alessandria si è verificato uno degli eventi teatrali più significativi della stagione: davanti a circa 150 spettatori la rappresentazione di Voci dalla collina, azione scenica dall’Antologia di Spoon River della compagnia Max Aub con la regia di Laura Bombonato.
Lo spettacolo (la cui preparazione è durata sei mesi) è registicamente splendido: geniale l’idea di fare dei 14 attori, tutti vestiti di nero, una processione, aperta e chiusa dai due maschi, che si muove, senza soluzione di continuità, in orizzontale, forma piccoli gruppi, si disfa, si incrocia, talora camminando lentamente talora correndo, in un perenne avanti e indietro. La sala, ampia, era adatta; l’atmosfera plumbea, connotata dal colore del buio, interrotto ogni tanto da piccole lampade, poste in terra nel retropalco, a illuminare tenui l’attore che recitava il proprio epitaffio.
Rispetto al testo, dove ogni personaggio prima di tutto sussurra il suo monologo in  prima persona, si eclissa e si passa al successivo, sia pure con continui richiami interni, Laura Bombonato ha optato con forza per la coralità; i morti sulla collina sono sodali, associati e ancorati dalle proprie storie tristi, tutte diverse e tutte eguali, dando al gruppo coerenza e coesione, mediante la sincronia dei movimenti e il dominante tono di voce sommesso, perché sono i defunti al cimitero che in prima persona sussurrano, non mai declamano, un pezzo della propria vita. Indi continueranno a dormire sulla collina.
prima persona, si eclissa e si passa al successivo, sia pure con continui richiami interni, Laura Bombonato ha optato con forza per la coralità; i morti sulla collina sono sodali, associati e ancorati dalle proprie storie tristi, tutte diverse e tutte eguali, dando al gruppo coerenza e coesione, mediante la sincronia dei movimenti e il dominante tono di voce sommesso, perché sono i defunti al cimitero che in prima persona sussurrano, non mai declamano, un pezzo della propria vita. Indi continueranno a dormire sulla collina.
Tutti i bravi i 14 attori; ricordo Danilo Seregni, che si staglia statuario nel monologo e guida il gruppo; dall’altro lato Flavio Speranza perentorio nella presenza scenica e nell’eloquio scandito con calma; Cristina Brunetto, l’unica che passa dal sussurro al registro in progressione più acuto; perfetta Simona Serra, dal volto ispirato, allargato dai riccioli, gli occhi vividi, sia nel ruolo di raccordo sia nel proprio personale; costante e misurata Cristina Sferrella, intenta a riempire gli stacchi, spostandosi dietro la fila, con la voce dal timbro costante e sicura dizione; Paola Gota porge il proprio epitaffio con un parlare rotto, spezzato, con frasi puntiformi per esprimere l’emozione che prova; sicura Daniela Musso, cui è toccato l’ingrato compito di iniziare; Daniela Cassina aristocratica nella sua innata eleganza di portamento; Monica Cortigiani perplessa e pensosa all’unisono; Nicoletta Mensi dal piglio deciso e perentorio; Marinella Scagliotti tenerissima e indifesa; poi Deborah Bencini, Federica Leone, Anna Ponzano, tutte ispirate e perfettamente inserite nella parte, ripeto corale, in cui l’individualità diventa un magma dai tratti indistinguibili, complici il buio e la sincronia dei gesti.
Splendido l’effetto dell’incipit sulla canzone che riprende “La collina”, l’introduzione (aggiunta da Masters nella seconda edizione del 1916, dopo l’inatteso strepitoso successo della prima del 1915), con i 14 corpi che simultaneamente si voltano indietro, piegandosi sinuosi, sensuali, ritmati, dalla positura verticale fino al lento e misurato abbandono, girandosi sul bancone retrostante. Un risultato scenico, che lascia lo spettatore fulminato e stupefatto da tanta bravura.
Leggendaria la storia autentica della traduzione della Pivano, studentessa del Liceo classico D’Azeglio di Torino, rimandata assieme a Primo Levi e Natalia Ginzburg in italiano alla Maturità, che aveva avuto Pavese come docente, il quale le prestò alcuni libri americani La Pivano ragazzina fu colpita dai versi “mentre la baciavo con l’anima sulla labbra/ l’anima d’improvviso mi sfuggì”, e tradusse in segreto l’Antologia, vergognandosi di tanto ardire. Pavese scoprì la traduzione, non disse nulla, la prese. La Pivano nel 1941 si laureò in lettere. Nel 1943 uscì il libro col titolo ( per ingannare la censura fascista): Antologia di San River, quasi subito sequestrato.
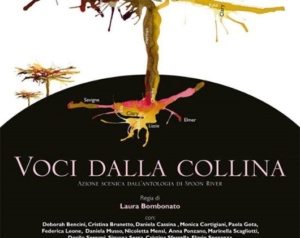 L’Antologia di Spoon River, contiene 244 epigrafi: 19 storie che coinvolgono 248 personaggi, appartenenti a tutti i ceti e mestieri sociali. Ciascuna poesia ha la forma dell’epitaffio, quello scritto sulla tomba; il linguaggio, in assenza di metrica, oscilla verso la prosa, anche per la deliberata schiettezza con cui Masters racconta storie di adulteri, aborti, tradimenti, omicidi, bancarotte, banche strozzine, ispirandosi anche a fatti e personaggi veri. I concittadini infatti protestarono (Gianni Riotta, La Stampa 29/12/16). Spoon River è un paese inventato, che rispecchia però due villaggi vicini, ove visse fino all’età adulta l’autore, quando fuggì a Chicago, destinata a diventare la capitale letteraria , per cedere poi il posto a NewYork. L’Antologia (che si ispira lontanamente alla silloge greco- ellenistico-bizantina Antologia Palatina, Masters aveva studiato il greco) sembra un romanzo “mancato”, redatto in prosa ritmata, come molta poesia del ‘900: una caustica critica del capitalismo, della magistratura corrotta, della violenza della polizia, della famiglia patriarcale ipocrita.
L’Antologia di Spoon River, contiene 244 epigrafi: 19 storie che coinvolgono 248 personaggi, appartenenti a tutti i ceti e mestieri sociali. Ciascuna poesia ha la forma dell’epitaffio, quello scritto sulla tomba; il linguaggio, in assenza di metrica, oscilla verso la prosa, anche per la deliberata schiettezza con cui Masters racconta storie di adulteri, aborti, tradimenti, omicidi, bancarotte, banche strozzine, ispirandosi anche a fatti e personaggi veri. I concittadini infatti protestarono (Gianni Riotta, La Stampa 29/12/16). Spoon River è un paese inventato, che rispecchia però due villaggi vicini, ove visse fino all’età adulta l’autore, quando fuggì a Chicago, destinata a diventare la capitale letteraria , per cedere poi il posto a NewYork. L’Antologia (che si ispira lontanamente alla silloge greco- ellenistico-bizantina Antologia Palatina, Masters aveva studiato il greco) sembra un romanzo “mancato”, redatto in prosa ritmata, come molta poesia del ‘900: una caustica critica del capitalismo, della magistratura corrotta, della violenza della polizia, della famiglia patriarcale ipocrita.
Edgar Lee Masters rivoluziona la giovane letteratura americana, imponendole il realismo., e facendole “scoprire la tragedia” (Agostino Lombardo). Censura la società puritana (pensiamo alla “Lettera scarlatta di Hawthorne del 1846) con un atteggiamento puritano. La formula apparentemente paradossale è abbozzata da Pavese e ripresa dalla Pivano. La posizione di Lee Masters è quella di colui che accusa la rigidezza moralistica e ipocrita del puritanesino in tutte le sue sfaccettature, ma lo fa da puritano, con la veemenza, l’atteggiamento ieratico del predicatore che accusa, diventato quasi un profeta. I puritani del Middle West erano convinti che la grande città fosse il luogo della corruzione e dell’immoralismo, mentre la campagna e i suoi villaggi si erano mantenuti ancorati ai valori tradizionali. Masters si schiera dalla parte del villaggio (come Walt Whitman, a cui si ispira, resta un regionalista) non per difenderlo bensì per mostrarne le nefandezze (vedi il grande film “Dogville” del 2003, con una memorabile Nicole Kidman del visionario Lars Von Trier).
Tutti i morti sulla collina di Spoon River “si lamentano di aver mancato la vita, con una consapevolezza austera e fraterna del dolore di tutti”: la vita è un cimitero di ambizioni fallite e sofferte. Non ci sono simboli, tutto è vivo, materiato, attuale. E non si tratta di “una rassegna di casi clinici”, perché Masters esprime “una consapevolezza austera e fraterna del dolore e della vanità di tutti”. Le “spettrali, dolenti, terribili, sarcastiche voci di Spoon River ci hanno commossi e toccati a fondo”. La ribellione, ricorrente nel libro, è quella di anime stanche, che si fanno schiacciare o scompaiono (Pavese,”La cultura” 1931 e “Il Saggiatore”, 1943, con tagli). Condannati, sono inchiodati per l’eternità al proprio epitaffio, eppure in esso ritrovano un pezzo nostalgico della vita perduta., ma possono solo ripeterlo verbalmente non cambiarlo.
Cahen cita lo choc, da cui il mondo letterario americano, insieme al grande pubblico, fu colpito. Masters aveva tolto loro ogni illusione, e aprì la strada alla Lost Generation, col suo linguaggio chiaro e sempre preciso. A lui si ispireranno Fitzgerald, Dos Passos, la Stein, Faulkner, Hemingway (Maxwell Geismar), non a caso tradotti da Pavese, Vittorini, Montale, e la Pivano, gli uni e gli altri i romanzieri e poeti della mia adolescenza.
Spettacolo da replicare assolutamente.





