Da tempo, come storico appassionato delle contaminazioni tra i generi, ho maturato una convinzione: da un lato, la fantascienza in quanto genere va disperdendosi, quasi “atomizzandosi”, nella letteratura tout court, generando la propria apparente fine svincolata da storici paletti caratterizzanti e creando degli ibridi tanto interessanti quanto indefinibili come la straordinaria saga del Mondo 9 del nostro Dario Tonani.
Dall’altro, in una sorta di incessante rumore di fondo che accompagna l’evoluzione di cui sopra, ecco constatare che un certo numero di scrittori, fantascientifici e non, da qualche anno condividono quasi per sincronicità junghiana l’analoga idea della “fine dei tempi”, in una sorta di mantra ossessivamente ripetuto in forma di libri (e di conseguenza in film e serial TV), che pare essere – parere peraltro non condivisibile – l’autentica ossatura della contemporanea letteratura apocalittica.
Nel dominio profondo dell’arte e della creatività esistono paradossi, ossimori e assiomi scarsamente approfonditi. Uno di questi suggerisce, come se ci trovassimo in un racconto alla Lovecraft, che diversi e disomogenei scrittori nel mondo (che all’inizio della loro insania letteraria neppure si conoscono ma forse riusciranno a incontrarsi, o quantomeno a collidere) possano iniziare a un certo punto a pensare, a creare, o a sognare, le identiche cose. Idee, trame, contenuti, soluzioni finali.
Le assonanze non sono di oggi. Nel 2008 mi capitò di leggere, l’uno in fila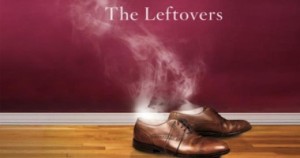 all’altro, Le invenzioni della notte dello scrittore austriaco Thomas Glavinic e il celeberrimo La strada di Cormac McCarthy. Proprio in quei mesi circolava sugli schermi la quarta versione filmica di I am legend, un ricco e per un po’ piacevole blockbuster con Will Smith che personalmente mi fece rimpiangere l’angosciante filmetto, troppo avanti per la sua epoca, girato da Ubaldo Ragona in bianco e nero all’EUR nell’anno 1964, ovvero L’ultimo uomo della Terra. E una domanda, inevitabile quanto retorica, titillava la memoria: Ma quanti anni fa scrisse I vampiri (primo titolo italiano di I am legend)?
all’altro, Le invenzioni della notte dello scrittore austriaco Thomas Glavinic e il celeberrimo La strada di Cormac McCarthy. Proprio in quei mesi circolava sugli schermi la quarta versione filmica di I am legend, un ricco e per un po’ piacevole blockbuster con Will Smith che personalmente mi fece rimpiangere l’angosciante filmetto, troppo avanti per la sua epoca, girato da Ubaldo Ragona in bianco e nero all’EUR nell’anno 1964, ovvero L’ultimo uomo della Terra. E una domanda, inevitabile quanto retorica, titillava la memoria: Ma quanti anni fa scrisse I vampiri (primo titolo italiano di I am legend)?
Facile risposta, nel 1954. E non c’è dubbio ancora oggi che Matheson vivesse, come tanti, la sua storia di scrittore fuori dal tempo. Aveva visioni durante le trance produttive di cui certo si rendeva conto. Come lui ce n’erano un altro paio: Ray Bradbury e James Ballard, ancora oggi culturalmente saccheggiati da una marea di contemporanei. Si potrebbe, si può, affermare con tranquillità che la triade Matheson /Bradbury/ Ballard stia all’apice di quel fantastico – gotico e apocalittico – che oggi, più che mai, si replica in diverse e interessanti protuberanze.
Ma torniamo a Glavinic e a McCarthy. Ai quali in anni successivi possiamo aggiungere il disturbante e avvincente Fine dello spagnolo David Monteagudo, la storia di nove amici di un tempo che si ritrovano per un misterioso appuntamento in uno chalet di montagna e di colpo tutto smette di funzionare: energia, telefonini e persino le automobili. Così altro non possono fare che scendere a valle per scoprire, come per il testo di Glavinic, che non esiste più alcun essere umano. E scomparire gradualmente a loro volta. Autori di ambiti quanto mai differenti, si può sottoscrivere. Mc Carthy è un grande americano (nato nel Rhode Island ma cresciuto nel Tennessee) che conosciamo da tempo; Glavinic è un giovane mitteleuropeo di cui, sino a Le invenzioni della notte, nulla ho mai saputo. Monteagudo è un ex operaio di una fabbrica di imballaggi; Fine risulta essere la sua opera prima e, per quanto consapevole dell’ombra di Bradbury o Ballard, lui dichiara come modelli ispirativi Rafael Sanchez Ferlosio e il teatro di Valle-Inclan. Ah, particolare non di poco conto: il critico militante non si sognerebbe mai di dichiarare la loro appartenenza al genere. Questi, come si dice all’anglosassone, sono scrittori mainstream.
E che hanno fatto questi tre narratori? Risposta semplice all’apparenza: hanno riscritto, sempre all’apparenza, I am legend di Matheson. Leggere per credere. Senza vampiri, va precisato. Non vorrei che vi sfiorasse il malsano sospetto che io stia accusando un gigante come McCarthy di plagio. Peraltro da un punto di vista puramente immaginifico, ha ragione Umberto Rossi che, nel suo imperdibile saggio Il poeta della devastazione (Pulp Libri 69, settembre-ottobre 2007), puntualizza che “la tradizione della letteratura fantascientifica catastrofica, in cui McCarthy entra a diritto con La strada, probabilmente discende da una delle opere meno note di Daniel Defoe, Il diario dell’anno della peste (1722), che tratta di un disastro tutt’altro che fantastico, la micidiale peste bubbonica del 1665”, che sarà d’ispirazione per il Wells della Guerra dei mondi e per le apocalissi ballardiane degli anni sessanta.
Visioni, dunque. Sempre più condivise da un più crescente numero di scrittori (grandi e piccoli, famosi e sconosciuti), che stanno tutti quanti pencolando sul baratro degli ultimi giorni (e non importa se quest’Apocalisse sia poi vera o falsa, ma importa quanto sia percepita e filosoficamente assimilata) e che ce lo stanno raccontando, ognuno a suo modo ma ognuno sempre più minacciosamente simile all’altro. Con un valore aggiunto che colpisce: la sincronicità.
Jonas, il giovane protagonista de Le invenzioni della notte, si sveglia il 4 luglio come tutte le altre mattine precedenti e, dopo il caffè (indispensabile anche in piena apocalisse), scopre che a Vienna non esiste più alcuna forma di vita e che sono rimasti solo più “gli oggetti”. Da lì a poco si renderà conto che il problema non è solo austriaco, ma riguarda tutto il vecchio continente e, per logica estensione, l’intero pianeta. Alla ricerca della fidanzata, Marie, intraprenderà una “strada” con destinazione Londra, trovando ovunque l’identico spettrale riscontro.
Ne La strada ci tuffiamo in un’analoga situazione, con qualche variante meno metafisica e più realisticamente definita. Un uomo e un bambino, un padre e un figlio, percorrono un pezzo d’America alla volta, creduta salvifica, dell’oceano: un paesaggio incenerito dove tutto, dagli alberi ai cadaveri, è ridotto a tronconi anneriti e che lascia fiocamente trapelare una minima ipotesi sugli eventi distruttivi. Attorno a loro pochissimi brandelli di un’umanità cannibale, residuali bestie feroci a tempo determinato. Senza futuro, anche se nelle ultime pagine McCarthy non chiude definitivamente la porta alla speranza.
Nel romanzo di Monteagudo, dopo la luce abbagliante che manda in tilt ogni fonte energetica, i nove protagonisti devono scendere in direzione della pianura per scoprire con terrore un mondo alieno e di colpo desertificato.
Letti l’uno di seguito all’altro, potrebbero proprio essere l’uno il seguito dell’altro: un “post – giorno finale”, filmato da due diverse soggettive, complete di coordinate geografiche. Neppure si fossero telefonati, né va comunque dimenticato il brodo cultural-primordiale in cui si agitano profezie vere o di mercato, alle quali ascrivere esempi storici o più recentemente acquisiti: vedi La nube purpurea di M. P.Shiel (scritto nel 1901!), il Morselli di Dissipatio HG, John Wyndham, John Christopher, Robert McCammon, Stephen King e persino l’italico Giacomo Gardumi con la sua inquietante Notte eterna del coniglio. Tralasciando le numerosissime derive cinematografiche. E televisive come lo splendido serial The Leftovers.





