Spesso, se qualcuno ci racconta di un parente o di un conoscente entrato all’Hospice, alziamo gli occhi al cielo. Il primo pensiero è che sia entrato per non uscirne più. In realtà non è così, all’Hospice non si va a morire, ma a vivere meglio ciò che resta da vivere. Varcando la soglia del Gelso, infatti, si respira un’aria davvero particolare, di serenità, di armonia e di umanità. La prima impressione che colpisce è che si stia entrando in casa di qualcuno e, in fondo, è così. L’Hospice (termine nato dall’unione delle parole home/hospital: casa/ospedale) è la casa dei medici, degli infermieri, dei volontari, ma soprattutto è la casa dei pazienti che la abitano, senza dimenticare il mitico cane Charlie, in città ormai una super star.
Per comprendere meglio quindi la storia degli hospice, del Gelso in particolare, e il significato di cure palliative, ci siamo fatti aiutare da Gabriella D’Amico, medico coordinatore dell’Hospice ‘Il Gelso’, e da Valeria Ghelleri, coordinatore infermieristico.
Questo non è un luogo di morte – precisa Valeria – ma un luogo dove si vengono a vivere gli ultimi giorni di vita. Noi abbiamo un rapporto umano con i famigliari, non ‘teniamo loro la mano’, ma abbiamo con loro un rapporto professionale che tiene conto dell’aspetto umano … potremmo definirla una ‘umanizzazione della cura’”.
Valeria Ghelleri oltre a coordinare il personale infermieristico è il punto di riferimento dei volontari; e alcuni di loro, mentre iniziamo la nostra conversazione, entrano ed escono dal suo ufficio per chiedere chiarimenti e informazioni. “I volontari dell’Associazione Fulvio Minetti sono coordinati da Piera Maestroni e la presidente è Francesca Biolatto” spiega.
Dottoressa D’Amico, cos’è un hospice?
“Gli hospice sono centri di cure palliative che fanno parte di una rete di assistenza ai malati, la cui filosofia di fondo è considerare prioritaria la qualità della vita e non l’aspettativa della quantità di vita residua. Il concetto è che con la cura palliativa si curano i sintomi di una malattia che, anche se non guaribile, può essere curata”.
Quando sono nate queste strutture?
“Tutto nasce nel 1999, grazie ad una bella legge promossa dall’allora ministro alla sanità Rosy Bindi, il cui motto era ‘non tutte le malattie sono guaribili, tutte sono curabili’. Tutte le malattie devono essere curate, indipendentemente dalla previsione di guarigione. Per cura palliativa si intende proprio la cura e il controllo dei sintomi di una malattia. Tornando alla legge 39/99, questa prevedeva lo stanziamento di finanziamenti per la realizzazione in ciascuna regione di strutture residenziali per l’assistenza ai pazienti non guaribili, stabilendo che fossero proprio le regioni a presentare i progetti che fossero conformi alle indicazioni del programma e tali da assicurare l’integrazione tra assistenza residenziale, assistenza domiciliare ed altri livelli assistenziali socio-sanitari e sociali erogati nei vari ambiti territoriali. L’obiettivo, infatti, era più ampio: costituire una rete integrata di assistenza, da realizzarsi attraverso il lavoro di equipe multi-disciplinari specializzate, incentrata prioritariamente sull’assistenza domiciliare. Nei casi in cui tale forma di assistenza non fosse stata praticabile, l’organizzazione della rete avrebbe dovuto prevedere il ricovero in apposite strutture residenziali – gli hospice appunto – ad elevato livello di prestazioni assistenziali”.
 “Si è assistito ad un vero e proprio cambio culturale – aggiunge Valeria – La legge Bindi ha inserito nei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) le cure palliative, che un tempo erano previste solo per i malati oncologici, ora sono per tutti i tipi di malattia degenerativa in fase avanzata come la SLA, il Parkinson, l’Alzheimer, ecc.”
“Si è assistito ad un vero e proprio cambio culturale – aggiunge Valeria – La legge Bindi ha inserito nei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) le cure palliative, che un tempo erano previste solo per i malati oncologici, ora sono per tutti i tipi di malattia degenerativa in fase avanzata come la SLA, il Parkinson, l’Alzheimer, ecc.”
Che origini hanno le cure palliative?
“La pioniera in questo campo è stata Cecyle Saunders negli anni 60/70. La Saunders è stata prima infermiera, poi, per non abbandonare la cura dei malati, assistente sociale e infine, consapevole che come infermiera non sarebbe stata ascoltata con la sufficiente attenzione, divenne medico. È stata lei a dare vita alla diffusione degli Hospice, sottolineando l’importanza delle cure palliative nella medicina moderna, assistendo i malati terminali fino alla fine della loro vita nel modo più confortevole possibile. Si era resa conto di quanto mancasse la parte di umanizzazione delle cure” – spiega Valeria Ghelleri.
“Il paziente deve essere preso in carico non solo per la malattia, ma per tutto, per l’insieme … nella sua globalità” aggiunge Gabriella D’Amico, e continua “le cure palliative sviluppate nei paesi anglosassoni, circa 20 anni dopo sono state introdotte anche qui, grazie al professor Vittorio Ventafridda, uno dei padri fondatori nel nostro Paese. Ed è alla luce della Fondazione Floriani, che con Ventafridda ha iniziato a parlare di questo tipo cure e di questa nuova filosofia di approccio ai pazienti, che decidemmo con Valeria e altri medici, infermieri e volontari di fondare l’Associazione Fulvio Minetti. In pratica un vero e proprio movimento filosofico che, in quegli anni, poteva essere portato avanti dalle associazioni di volontariato.”
l’insieme … nella sua globalità” aggiunge Gabriella D’Amico, e continua “le cure palliative sviluppate nei paesi anglosassoni, circa 20 anni dopo sono state introdotte anche qui, grazie al professor Vittorio Ventafridda, uno dei padri fondatori nel nostro Paese. Ed è alla luce della Fondazione Floriani, che con Ventafridda ha iniziato a parlare di questo tipo cure e di questa nuova filosofia di approccio ai pazienti, che decidemmo con Valeria e altri medici, infermieri e volontari di fondare l’Associazione Fulvio Minetti. In pratica un vero e proprio movimento filosofico che, in quegli anni, poteva essere portato avanti dalle associazioni di volontariato.”
Come si è arrivati alla decisione di realizzare l’hospice ‘Il Gelso’?
“La legge prevedeva di finanziare la creazione degli hospice in strutture preesistenti da convertire. Il primo fu aperto in Lombardia, il secondo in Piemonte e il terzo in Emilia Romagna. Nella struttura dove ora sorge Il Gelso c’era l’ente comunale assistenziale (ECA) per gli indigenti che verso la fine degli anni ’70 chiuse il dormitorio, mantenendo attivo solo il servizio di distribuzione del cibo. Con l’alluvione del ’94 si è allagato successivamente è stato ristrutturato, per creare un luogo di accoglienza per disabili. Nel frattempo arriva la legge Bindi che, a fronte di quando accadeva in Inghilterra, decide di avviare gli Hospice anche in Italia.
Nel 2004, 2005 grazie all’interessamento e al lavoro sinergico di un gruppo sparuto di persone che avevano a cuore la creazione di un hospice in città, siamo riusciti ad ottenere il finanziamento dalla regione, il comune ci fornì la struttura, l’ASL si accollò la parte relativa alla ristrutturazione e all’ASO andò il compito di gestire.
La ristrutturazione durò circa due anni, tenendo conto delle caratteristiche strutturali specifiche definite nella legge che prevedeva che gli hospice rappresentassero una sorta di ‘casa/ospedale’, il termine deriva, infatti, dall’unione delle parole ‘home’ e ‘hospital’. Tant’è vero che all’hospice si possono portare oggetti personali, addirittura piccola mobilia, gli animali domestici e i famigliari possono dormire in stanza con il ricoverato.”
 Da chi dipende ‘Il Gelso’? Dall’ospedale o dall’ASL?
Da chi dipende ‘Il Gelso’? Dall’ospedale o dall’ASL?
“Dall’ASL, ma eravamo dipendenti dell’ospedale allora, io ero in anestesia e gestivo l’ambulatorio di terapia del dolore … – afferma D’Amico – All’inizio l’ospedale avrebbe dovuto gestire l’hospice, ma bisognava capire come. Nel frattempo doveva essere inaugurata anche la struttura del Borsalino, sempre in gestione all’ospedale. Da lì la scelta di proporre il distacco di una parte di personale dipendente dell’ospedale (ASO) all’ASL per permettere a questa la gestione diretta. In provincia c’erano (e ci sono) l’associazione Vitas di Casale, Cucchi di Tortona e Vela di Ovada … da loro l’ospedale è gestito dall’ASL, per cui hanno incontrato meno problemi rispetto ad Alessandria dove l’ospedale (ASO) e l’Azienda Sanitaria Locale sono due enti distinti. Fu così che fui distaccata qui all’hospice insieme ad un infermiere e con noi portammo l’ambulatorio di terapia del dolore. In seguito fu istituito il CUP al Patria, ma l’organico doveva ancora essere implementato, per cui sollecitai la scelta di Valeria che allora lavorava in cardiochirurgia.”
“Allora avevo appena terminato un corso di formazione come coordinatore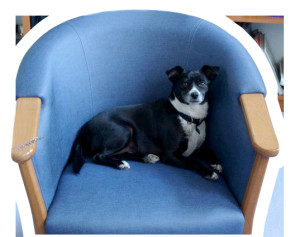 infermieristico, per cui entrai all’hospice con questa mansione.” conferma la Ghelleri “Nel 2007 è stata ufficialmente aperta la struttura e nello stesso periodo arrivò anche Charlie, il nostro ‘collega’ che si occupa di pet therapy” – sorride Valeria – “Charlie è molto autonomo, sceglie da solo le stanze in cui entrare ed è di grande sollievo per i pazienti a cui fa compagnia, ma soprattutto per i famigliari a cui dispensa coccole e affetto.”
infermieristico, per cui entrai all’hospice con questa mansione.” conferma la Ghelleri “Nel 2007 è stata ufficialmente aperta la struttura e nello stesso periodo arrivò anche Charlie, il nostro ‘collega’ che si occupa di pet therapy” – sorride Valeria – “Charlie è molto autonomo, sceglie da solo le stanze in cui entrare ed è di grande sollievo per i pazienti a cui fa compagnia, ma soprattutto per i famigliari a cui dispensa coccole e affetto.”
Attualmente quanti degenti ospitate e come avviene la presa in carico?
“La segnalazione può avvenire da parte del medico di famiglia, dal paziente direttamente o da un famigliare. La struttura conta sedici posti letto, ora tutti occupati, mentre tra i trenta e i quaranta pazienti sono seguiti a casa, circa venti ogni mese sono ambulatoriali, senza contare quelli seguiti presso le case di riposo, ecc. La presa in carico del paziente infatti può avvenire a domicilio, a livello ambulatoriale, oppure, qualora le prime due soluzioni non fossero possibili perché i bisogni assistenziali sono più alti, attraverso il ricovero.”
I pazienti seguiti sono tutti della provincia di Alessandria?
“No, qui possono essere ricoverati pazienti di tutto il Piemonte, ma anche da fuori purché siano autorizzati dalla regione di appartenenza”.
 Quanti dipendenti ci lavorano?
Quanti dipendenti ci lavorano?
“Attualmente vi sono 7 infermieri, un coordinatore infermieristico, 13 operatori socio sanitari, un responsabile medico, 2 medici più uno part time in supporto da Tortona”
In che rapporti siete con l’ospedale?
“Abbiamo un rapporto ottimo direi. Da oncologia arrivano direttamente qui al Gelso, dove possiamo fornire più assistenza rispetto all’ospedale. In ospedale c’è più tecnologia, si dispensa una cura attiva, per cui una volta terminato il ciclo di trattamenti della fase acuta il paziente viene dimesso o indirizzato verso altre strutture (continuità assistenziale, hospice, residenze per anziani o rientro al proprio domicilio). Sempre più spesso però cure attive e cure palliative vengono somministrate in simultanea (simultaneous care). Non si tratta più di garantire la cura attiva per un malato oncologico, per esempio, ma è anche necessario saperne valutare e curare i sintomi per migliorare la qualità della vita e la performance dai risultati terapeutici in corso. Tant’è vero che simultaneous care è un concetto non solo per i malati oncologici, ma rivolto a tutti gli ambiti della malattia e in tutte le sue fasi. Deve essere obbligo e uno strumento per tutti i medici e gli infermieri. Non è un movimento culturale ma un modo di curare!”





