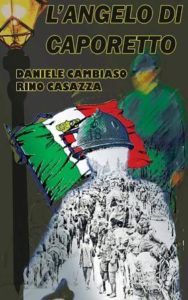Quando si parla di legal thriller, il pensiero del lettore scivola subito in direzione dei grandi successi di autori (letterari e cinematografici) inglesi e americani. Si tratta di un genere narrativo che ha investito il mercato editoriale dando risalto alle figure di giudici e avvocati e alle procedure giudiziarie (spesso molto complesse) necessarie per dipanare fatti criminosi e assicurare alla giustizia quanto alla verità dei fatti il vero colpevole “aldilà di ogni ragionevole dubbio”.
A partire da Il Buio oltre la Siepe della scrittrice americana Harper Lee, fino al notorio Perry Mason in bianco e nero nell’omonima serie TV legata al personaggio di Erle Stanley Gardner, si è passati rapidamente a nomi di cassetta quali John Grisham, Michael Connelly, Paul Levine, Scott Turow , Lisa Scottoline, formando una lista di nomi destinata ad allungarsi ad ogni sfornata di romanzi.
Quando si parla di legal thriller tutto italiano, il pubblico dei lettori nostrani sembra arricciare il naso e preferire comunque lo stampo anglosassone o d’oltreoceano. Quindi, pur avendo un discreto numero di autori che si sono cimentati nel ruolo (da Gianrico Carofiglio a Giancarlo De Cataldo, perlatro entrambi giudici di esperienza) gli aspetti più investigativi e noir hanno rubato spazio alla procedura vera e propria.
Con L’Angelo di Caporetto la rodata coppia Daniele Cambiaso-Rino Casazza (già ospiti di AlLibri con Nora, una donna e La logica del Burattinaio) ed edito dalla casa editrice Algamasi si è messa in gioco con questo genere entrando nel mondo di un tribunale militare in un preciso contesto storico.
Siamo nell’aprile 1919, a Roma. Gli strascichi della “Grande Guerra” sono ancora vivi, si riunisce una Commissione Militare che deve accertare l’identità di un militare sconosciuto, resosi protagonista di atti eroici. Lo chiamano l’Angelo, ma nessuno è ancora riuscito ad individuarlo. Come testimone chiave per risolvere il mistero viene chiamato il capitano Sergio Moretti del Servizio Informazioni, rimasto ferito in un oscuro episodio avvenuto durante lo sfondamento austriaco a Caporetto e suo compagno di prigionia a Mauthausen. Un militare che perso parzialmente la memoria, ma i cui appunti manoscritti possono portare alla verità. La trama di dipana sullo sfondo reale della più clamorosa disfatta bellica italiana, dove nulla è come sembra e dove i confini tra bene male si annullano: perché l’unica cosa che conta è sopravvivere.
Tratto da L’angelo di Caporetto,di Daniele Cambiaso-Rino Casazza
Il primo capitolo:
L’inchiesta (Prima parte)
Roma, 14 aprile 1919
La primavera romana del 1919 è luminosa e languida, con una punta d’afa.
Alle sette e trenta del mattino, i palmizi nel cortile grande di Palazzo Esercito, un po’ incongrui nella città dei pini, si mostrano vividi e floridi.
Il Caporale che, assieme a un soldato presidia in uniforme inappuntabile la porta austera dell’aula al terzo piano, si gode la luce che dalle ampie vetrate invade il corridoio.
Quell’ala dell’edificio, spopolata e silenziosa, dà l’impressione di un tempio.
Non è poi tanto strano che la sede del Regio Stato Maggiore dell’Esercito somigli a un luogo di culto.
Dopotutto l’arte della guerra, nella sua implacabile ritualità, sa molto di religioso.
La guerra, quella con la “g” maiuscola, che tutti chiamano “grande”, è terminata nel novembre precedente, lasciando strascichi pesanti.
La Patria ne è uscita vittoriosa, ma ad un prezzo carissimo.
Il Caporale Biagio Cimaglia ha avuto la fortuna di non andare al fronte, scampando alla terribile falcidie testimoniata, penosamente, dalla legione delle vedove e degli orfani.
Poi ci sono i reduci.
Un postumo delicato di ogni conflitto che, fin dai primi mesi trascorsi dalla firma dell’armistizio di Villa Giusti, si preannuncia particolarmente spinoso.
Uno degli uomini che Cimaglia sta attendendo è, appunto, un reduce.
Anzi, un eroe di guerra, insignito della medaglia d’argento al valore per il coraggio dimostrato nel momento più drammatico del conflitto, quando il baratro della sconfitta sembrava a un passo, e per le sofferenze sopportate nell’anno di deportazione nel lager di Mauthausen.
Cimaglia non nasconde la curiosità di conoscere da vicino il Capitano Sergio Moretti, soprattutto per il secondo capitolo della sua storia.
Come si esce dalla prigionia in un campo di concentramento?
Gli verrebbe voglia di chiederlo direttamente al Capitano, ma sa che non potrà permettersi una confidenza del genere.
La presenza sua e del commilitone a piantonare la porta in legno massiccio, sovrastata dalla scritta in bassorilievo Corte Marziale, certifica la solennità dell’occasione.
La Commissione Speciale, nominata dal Ministro della Guerra, è un caso raro nella storia dell’esercito.
Normalmente, simili organismi recano il nome che ammonisce chi ne varca la porta: inflessibili tribunali che sanzionano, dopo un’indagine più o meno sommaria, le indiscipline dei militari.
Durante la “Grande Guerra”, il Caporale lo rammenta spesso, le Corti Marziali avevano avuto un surplus di lavoro.
Era stato un conflitto difficile e doloroso, come nessun altro.
Per la maggior parte del tempo era stata una “guerra di posizione”, trincea contro trincea, con tentativi di sfondamento all’arma bianca dall’una e dall’altra parte.
Solo che, a differenza delle precedenti campagne, l’uso a scopo difensivo della mitragliatrice, un’arma fino ad allora considerata troppo statica e scomoda, aveva mostrato una devastante efficacia, permettendo di respingere i fanti lanciati all’assalto. Erano poi state utilizzate in larga scala altre nuove armi micidiali, come il carro armato e i gas asfissianti, che avevano reso disumano il conflitto.
Gli episodi di insubordinazione agli ordini, talora di vera e propria ribellione per codardia, e persino per tradimento, non si contavano. Moltissimi soldati erano finiti sotto il fuoco del plotone di esecuzione.
La “Grande Guerra”, pensa il Caporale Cimaglia, sarà ricordata per il contrasto drammatico tra il dovere del sacrificio estremo e l’istinto di sopravvivenza.
Per questo, e per un fiume di parole.
Al fronte hanno ritrovato una montagna di carta: quasi tutti i militari alfabetizzati hanno riempito pagine e pagine di diario nelle lunghe ore di attesa tra un assalto suicida e l’altro.
Il Caporale ha ottenuto a fatica la licenza elementare e non ama molto leggere. Ma, poiché al conflitto hanno partecipato tutti, anche gli scrittori, non dubita che presto la letteratura di guerra si arricchirà.
La Commissione inizia i lavori in quel piacevole, anche se un po’ troppo caldo, giorno di aprile. Ma stavolta non deve punire soldati infedeli e senza onore, additandoli al pubblico disprezzo: deve strapparne uno all’infamia, restituendogli la dignità persa ingiustamente.
A molti il fatto ricorda un’iniziativa di cui si era parlato in Francia e Inghilterra durante il conflitto, e che sta trovando sempre più seguito in Europa dopo la fine delle ostilità: omaggiare il sacrificio delle Forze Armate onorando il cosiddetto “Soldato sconosciuto” ovvero un militare reso irriconoscibile dalla morte sul campo di battaglia, simbolo dell’eroismo più alto, quello anonimo.
Il Caporale Cimaglia, anche se non lo ammetterebbe mai, trova che una celebrazione del genere – e certo anche il Regno d’Italia non potrà a lungo astenersene… – abbia un che di macabro.
Ma non c’è più tempo per divagare: dal fondo del corridoio echeggia un rumore di passi.
La figura che sta arrivando è inconfondibile: il Tenente Generale Raimondo Alfieri.
L’alto ufficiale spiccherebbe anche se la sua altezza non sfiorasse il metro e novanta. A metterlo al centro dell’attenzione basta il portamento eretto, un vero inno alla severità marziale.
E poi la testa rasata con cura, esibita con fierezza.
Sì, quell’uomo snello, quasi filiforme, ma energico ad onta di un’età che supera di parecchio la sessantina, quando compare ispira immediata deferenza. Anche ai civili vien da mettersi sull’attenti e salutare battendo i tacchi.
Il “Generale” per antonomasia.
Più adatto, in effetti, ad una Corte Marziale che ad una Commissione speciale con scopi da “redentori”.
Il Tenente Generale teneva molto a presiederla ed è stato accontentato.
Entrato da poco nello Stato Maggiore, viene da una gloriosa esperienza di comando sul campo. La sua divisione ha combattuto con valore sul Carso e poi a Vittorio Veneto.
Amatissimo dalla truppa, la sua voce si era levata tutte le volte che qualcuno aveva tentato di sminuire le virtù guerresche del Regio Esercito.
«Nelle nostre fila – amava ripetere – le mele marce risaltano di più perché sono rare».
Al primo apparire di Alfieri, il Caporale Cimaglia ha fatto un cenno al soldato che lo accompagna, Luca Salvini, un militare di leva scelto per il bell’aspetto e il fisico atletico.
Questi, adeguatamente catechizzato sull’importanza di mostrare il meglio di sé in presenza del Presidente della Commissione, s’è subito irrigidito in una posa plastica da soldatino di piombo: mento alto, braccio destro steso lungo il fianco e fucile Carcano mod. 91 a baionetta inserita, stretto sul calcio con la sinistra e appoggiato alla spalla.
Anche Cimaglia s’impettisce, preparandosi ad accogliere l’alto ufficiale con un irreprensibile saluto militare.
Dall’altro capo del corridoio, dove si allunga lo scalone che sale dai piani inferiori, si sente un nuovo scalpiccio.
Cimaglia vorrebbe voltarsi per guardare chi stia sopraggiungendo, ma non osa: il Tenente Generale li ha ormai raggiunti ed è certo che ora stia osservando lui e Salvini col suo temuto sguardo scrutatore.
La persona si avvicina con incedere lento e un po’ faticoso, nulla a che vedere non solo con l’inconfondibile cadenza secca e imperiosa del passo di Alfieri, ma nemmeno con quella sicura e ritmata del Maggior Generale Carlo Maria Bentivegna, né del Colonnello Pasquale Aderlini di Roccaferro, gli altri membri della Commissione, abituali frequentatori del palazzo.
Dunque, deve trattarsi di Moretti.
Cimaglia ne riceve conferma dal comportamento del Tenente Generale che, abituato a compiacersi di uno scatto sull’attenti impeccabile come il loro, stavolta passa oltre senza degnarli della minima attenzione, attirato dalla nuova presenza.
«Capitano! Si faccia abbracciare!»
La voce di Alfieri – in uno spiccato accento bresciano che non gli toglie autorevolezza neppure nelle imitazioni caricaturali dei soldati buontemponi – risuona carica di emozione.
Il Tenente Generale tutto d’un pezzo va famoso per questi slanci genuini, che ne rendono più apprezzata l’immagine.
Cimaglia e Salvini non possono ora fare a meno di voltarsi: Alfieri si fa incontro a un Capitano dal viso smunto, cui la divisa d’onore va visibilmente larga.
Sergio Moretti è un uomo sulla trentina, di altezza superiore alla media, ma non regge il confronto con lo svettante Alfieri. Li accomuna la magrezza, anche se quella del Tenente Generale è di costituzione, mentre quella del Capitano è un evidente strascico, in via di recupero, degli stenti patiti nel lager.
L’incontro è commovente. Alfieri avvolge tra le lunghe braccia Moretti con un trasporto che pare sincero, nient’affatto formale. È l’abbraccio virile di un padre al figlio. Il Capitano è sorpreso e imbarazzato.
Poi il Tenente Generale molla la presa: «Era da tempo che desideravo farlo! Lei è un esempio del valore e della tenacia del nostro glorioso esercito!».
Nessuno dei presenti trova retoriche le sue parole.
Moretti, ancora frastornato, scatta sull’attenti: «Grazie, signore!».
Il Caporale Cimaglia deve ammettere che, pur debilitato, fa la sua bella figura. Lo aiuta l’abbigliamento di gala: il berretto in castorino grigioverde, la giubba con spalline metalliche d’argento, i guanti bianchi, i pantaloni alla zuava con bande laterali, la bandoliera di gallone d’argento incrociata sul petto con la sciarpa azzurra, e soprattutto la sciabola con pendagli e dragona. Spicca, appesa sopra il taschino sinistro della giubba, la medaglia d’argento.
«Riposo, Capitano» risponde Alfieri. E subito, in ossequio al proprio personaggio, aggiunge: «Non si aspetti altre smancerie da me. Sono dell’idea che i soldati vadano trattati allo stesso modo perché tutti potenziali eroi. Lei ha solo avuto la possibilità di dimostrarlo, encomiabilmente, per le particolari circostanze in cui si è trovato».
In quel momento, in fondo al corridoio echeggia, amplificato dal silenzio e dall’ampiezza del luogo, l’ennesimo rumore di passi, cui si accompagna il bisbiglio di una conversazione.
I due ufficiali davanti alla porta scorgono sopraggiungere due colleghi amichevolmente a braccetto.
Indossano la divisa ordinaria, come Alfieri. Unica differenza, portano il berretto, che il Tenente Generale appena può evita, orgoglioso del proprio cranio glabro.
A rigore, la “grande uniforme” di Moretti stonerebbe, ma Cimaglia pensa invece che sia adattissima a un eroe di guerra. Nessuno avrà da ridire vedendogliela indosso.
I due nuovi arrivati, il Maggior Generale Carlo Maria Bentivegna e il Colonnello Pasquale Aderlini di Roccaferro, entrambi sulla cinquantina, sono due comandanti operativi distintisi nel fresco conflitto, distaccati ad hoc presso lo Stato Maggiore per l’importante incarico.
Nel 1915 Bentivegna era Tenente Colonnello e Aderlini Maggiore. Tra i più validi protagonisti della “Grande Guerra”, hanno ricevuto entrambi una doppia promozione.
Bentivegna ha svolto l’intera carriera nel Servizio Informazioni, lo stesso cui appartiene Moretti.
Aderlini ha retto un battaglione nella seconda battaglia del Monte Grappa, combattuta dall’Armata agli ordini del Generale Stefano Giardino.
La diversa vocazione dei due, uno appartenente allo spionaggio militare – la cui importanza si sta accrescendo sino ad acquisire la denominazione anglosassone, molto più nobile, di “intelligence” – l’altro alla compagine impegnata sul campo, non ha impedito loro di familiarizzare.
Neppure lo hanno impedito il diverso aspetto fisico e la diversa provenienza regionale.
Bentivegna è di famiglia piemontese con antiche tradizioni militari, Aderlini è l’ultimo rampollo di una dinastia nobile calabrese che ha servito prima il Regno Delle Due Sicilie e adesso il Regno d’Italia.
Bentivegna, snello ed elegante, brizzolato, altezza comune, ha il viso intenso di un attore. Incontra grande successo con le donne e, nonostante sia sposatissimo con una nobile conterranea, si dice contraccambi volentieri l’interesse femminile.
Aderlini, marchese di Roccaferro, di aristocratico ha i modi, ma non l’aspetto. È così lontano dallo stereotipo nobiliare che chi lo vede in fotografia lo scambia, di primo acchito, per un rozzo popolano.
Basso e tozzo, le gambe storte, è di faccia squadrata, calvo, con una mascella enorme e il collo corto. Se l’antropologo criminale Cesare Lombroso fosse stato chiamato a classificarlo, ne avrebbe tratto di sicuro conclusioni imbarazzanti.
La pessima impressione iniziale svanisce appena ci si relaziona con lui: è colto, facondo e acuto. Soprattutto, i modi sono davvero signorili.
Una contraddizione vivente tra immagine e sostanza.
Il suo stile di comando, apprezzato da sottoposti e superiori, è equilibratissimo. Così come rinomata è la competenza strategica.
Avvicinandosi a braccetto, la sgraziata coppia ad “articolo il” dei due alti ufficiali si accorge del gruppo fermo davanti alla porta dell’aula e si scioglie per affrontare in modo più consono il severo Presidente.
«Bene, bene – nota questi mentre ne riceve il saluto – mi fa piacere vedervi così affiatati, signori! Questo giovanotto… – e indica il Capitano – …è la celebrità che abbiamo l’onore di avere con noi, e che speriamo possa aiutarci a raggiungere l’importante obiettivo che ci hanno affidato!»
Alfieri estrae dal taschino della giacca un orologio a catena dorato: «Sono le sette e quarantasei. Mi compiaccio che siate arrivati tutti con l’anticipo che ogni soldato prudente deve osservare. Suppongo che il Maresciallo Codeluppi sia già dentro per preparare la seduta».
«Signorsì!» conferma Cimaglia.
Il Maresciallo Capo Ersilio Codeluppi, collaboratore di lungo corso dello Stato Maggiore, è il Segretario della Commissione. In effetti è entrato nell’aula almeno tre quarti d’ora prima. Col suo fare bonario di modenese doc, aveva anticipato il gesto del saluto della guardia davanti alla porta esclamando: «Comodi, comodi!». Poi aveva aggiunto, strizzando l’occhio: «Non siamo a una parata militare, ragazzi!»
Cimaglia lo conosce bene: persona modesta e alla mano, in linea con una notevole grassezza che lo fa somigliare ad un salumiere delle sue parti – di nascosto la truppa lo chiama “maresciallo salciccia”-, non bisogna sottovalutarlo. È estremamente preciso e scrupoloso.
Considerato che gli mancano un paio d’anni alla pensione e che ha passato quasi tutta la carriera allo Stato Maggiore, rappresenta una garanzia.
(fine prima parte. Continua domenica 16 settembre)