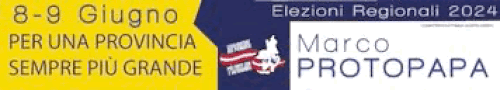Dalle cronache dei giorni scorsi, altri segnali di resa del made in Italy: i cinesi si comprano il mitico marchio Sergio Tacchini (chi giocava a tennis negli anni Ottanta, anche a livello amatoriale, non può non dispiacersi almeno un po’: vestivano Tacchini, tra gli altri, anche McEnroe e Connors, nella foto), mentre una holding di Taiwan acquisisce il controllo della Berloni, che da cinquant’anni vuol dire arredamento, cucine in particolare.
Ma sono solo due dei tanti esempi in cui ci si imbatte sfogliando le cronache economiche di queste settimane, di questi mesi e probabilmente dei prossimi.
E già va bene quando appunto si tratta di aziende che non chiudono, ma semplicemente passano di mano. Personalmente rimaniamo convinti che, in genere, dopo una fase di transizione il rischio che anche le produzioni (dopo ‘la testa’ e il portafogli) siano trasferiti altrove è alto, altissimo. Ma questa è la situazione dell’Italia 2013, e non è che si possano pretendere atti di eroismo individuali. Il buon imprenditore è colui che sa quando è il momento di rischiare, crederci e investire, ma anche quando è il momento di mollare, per massimizzare il profitto (non venitemi a raccontare che quello non è l’obiettivo primario: lo è sempre e comunque), o comunque per smobilitare evitando guai peggiori.
Però attenzione: non è il mondo intero che sta tirando i remi in barca, e neppure tutto l’Occidente. Anzi. Leggetevi questo bel reportage sull’economia statunitense,
che riprende alcuni temi e riflessioni che amici italiani trasferitisi negli States per scelta di vita e lavoro ci ripetono da tempo. Ossia, altrove i motori dell’economia sono già ripartiti, eccome. Certo, con una serie di differenziazioni importanti, e per quanto ci riguarda anche con qualche punto interrogativo sulla ‘tenuta’ e la solidità prospettica di un sistema, quello americano, che pare tutto orientato all’innovazione tecnologica e al consumo (che là raggiunge livelli da vera perversione e patologia), al punto da collocare altrove nel mondo la produzione dei beni e prodotti materiali. Però è un fatto che gli States crescono, e che da loro, come nel resto del mondo civilizzato, rimane valida l’equazione ‘maggior specializzazione professionale dei singoli, maggior guadagno per i singoli stessi’. Mentre da noi le associazioni imprenditoriali e professionali lanciano spesso appelli del tipo “andate all’istituto tecnico e poi a lavorare: studiare troppo è controproducente”, per dire come è messo il nostro tessuto economico, e dove aspira a collocarsi nello scacchiere internazionale.
L’altro giorno, su un giornale locale, i dipendenti di una piccola impresa dell’alessandrino hanno comprato uno spazio pubblicitario per ringraziare il datore di lavoro (il padrone, si sarebbe detto una volta) perchè tiene duro, e continua a farli lavorare e a pagarli. Tutto bello, tutto commovente e onesto. Ma, se questa è la logica, siamo al capolinea, non al rilancio: ce ne rendiamo conto, vero?
E attenzione: ‘occhio’ agli imbroglioncelli di casa nostra che già si preparano a ‘spacciare’ il prevedibile ‘rimbalzo’ della crescita internazionale come un superamento della crisi nostrana.
L’Italia (come la Grecia, e come il Portogallo e la Spagna, che pure ha il vantaggio di un’età media della popolazione molto bassa) deve fare i conti con una crisi di sistema, strutturale. Che non può essere superata semplicemente facendoci trasportare dal vento internazionale. O prendiamo atto di questo, come prerequisito per provare ad uscirne (con i sacrifici del caso, e con tempi lunghi, e capacità di progettare), oppure continueremo a scivolare, convinti di aver intrapreso la risalita. Questione di prospettiva, e di modi di guardare.